In un giorno feriale all’inizio di luglio andavamo al mare, mia zia I. ed io. Ci accompagnava con la sua spaziosa topolino giardinetta il signor F. che normalmente usava l’auto per il trasposrto di grossi mazzi di paglie di pioppo che servivano alla manifattura di trecce, esportate in tutto il mondo sotto forma di cappelli estivi o di robuste sporte per fare la spesa, leggere, capaci e durevoli antenate delle sportine di plastica. Si partiva la mattina ad un’ora confortevole con una piccola valigia, una in due.

Dopo una ventina di kilometri ombreggiati da pioppi cipressini si raggiungeva la via Emilia, poi sempre dritto, rigorosamente controsole fino al mare, attraversando il centro di tutte le città e di tutti i paesi, come dio comanda. Circonvallazioni, autostrade, svincoli, sensi vietati e altre astruserie non c’erano ancora ed il pigro traffico di allora non ne sentiva alcun bisogno. Le biciclette, numerose, e i carri agricoli condividevano la carreggiata con i mezzi a motore: poche auto e ancor meno camion, soprattutto Dodge e Bedford, residuati di guerra convertiti al trasporto di maiali ed altre virtuose merci di pace.
Il nostro pilota non era certo Nuvolari e la topolino non era una Ferrari, ma per l’ora di pranzo si era sempre tranquillamente pronti a sedersi a tavola, dopo i convenevoli d’obbligo con la matriarca che gestiva l’albergo insieme con le sue quattro figlie, il figlio sinistrato ed il pleonastico “vecchio”, assaggiatore di Sangiovese a tempo pieno.
La sala da pranzo era fresca, spaziosa e i tavoli grandi e ben distanziati. La cucina, tradizionale e senza fronzoli, meritava il consenso senza riserve di un pubblico indigeno competente, abituato a mangiare bene a casa propria. I pochi svizzeri e tedeschi, avanguardie dei futuri eserciti di turisti affezionati, si leccavano i baffi ed i fiaschi impagliati avevano il posto d’onore al centro dei loro tavoli. Dalle ampie finestre, sotto la luce abbacinante del meriggio, si vedevano le alte dune popolate di ginestre, unico schermo alla vista del mare che si scorgeva brillare solo attraverso pochi varchi.
Le tende di ruvida tela, ornata con i tradizionali decori ruggine di Romagna, ben distanziate lungo una sola fila, gettavano un’ombra rattrappita sulla sabbia dorata, lambita dal mare verde e trasparente, deserto a quell’ora. Rare erano le paranze all’ancora nell’acqua bassa, con le larghe vele triangolari dipinte di rosso, di giallo e di verde a formare disegni elementari come quelli dei bambini.


 Chi non sbadiglia in compagnia è un ladro e una spia, potremmo dire parafrasando la nota frase che si usava da bambini quando, durante una scampagnata, ci si ritrovava a fare pipì tutti insieme ai margini di un campo di frumentone.
Chi non sbadiglia in compagnia è un ladro e una spia, potremmo dire parafrasando la nota frase che si usava da bambini quando, durante una scampagnata, ci si ritrovava a fare pipì tutti insieme ai margini di un campo di frumentone.



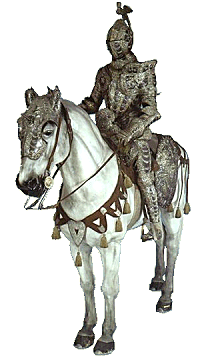
 anche il cuore, se vogliamo. Secondo te, allora, non sarebbero semianalfabeti solo gli scrittori viscerali
anche il cuore, se vogliamo. Secondo te, allora, non sarebbero semianalfabeti solo gli scrittori viscerali


 NEW YORK – I ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston hanno trovato l’origine di cuscinetti e pieghe adipose. La scoperta, pubblicata sulla rivista dell’ Accademia americana delle scienze , Pnas, apre la via alla possibilità di mettere a punto farmaci di combattere sia l’obesità sia le altre malattie come il diabete. Stando alla ricerca, il gene controlla l’attività dell’enzima chiamato ACC2 (acetil-CoA-carbossilasi-2) che immagazzina i grassi…i ricercatori hanno concluso così che l’enzima ACC2 non soltanto svolge un ruolo chiave nella comparsa di obesità e diabete, ma potrebbe diventare un bersaglio di futuri farmaci in grado di controllare le capacità dell’organismo di bruciare i grassi.
NEW YORK – I ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston hanno trovato l’origine di cuscinetti e pieghe adipose. La scoperta, pubblicata sulla rivista dell’ Accademia americana delle scienze , Pnas, apre la via alla possibilità di mettere a punto farmaci di combattere sia l’obesità sia le altre malattie come il diabete. Stando alla ricerca, il gene controlla l’attività dell’enzima chiamato ACC2 (acetil-CoA-carbossilasi-2) che immagazzina i grassi…i ricercatori hanno concluso così che l’enzima ACC2 non soltanto svolge un ruolo chiave nella comparsa di obesità e diabete, ma potrebbe diventare un bersaglio di futuri farmaci in grado di controllare le capacità dell’organismo di bruciare i grassi.