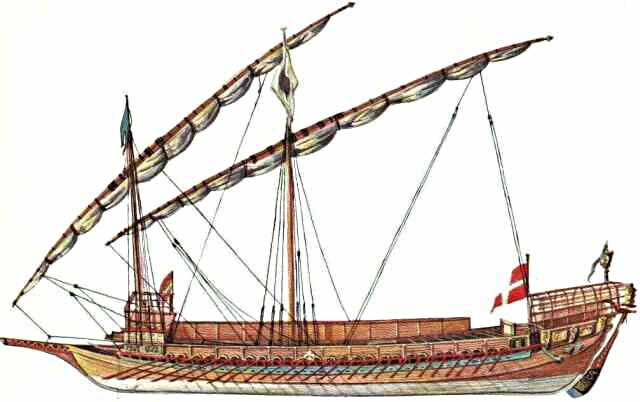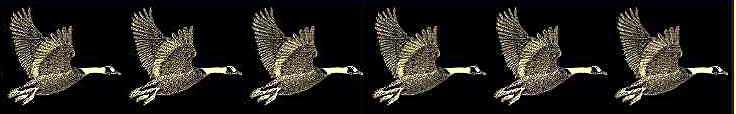mer. 01 ottobre 2003
 “La bacchetta del teatro conta fino a 24..”
“La bacchetta del teatro conta fino a 24..”
Anche le filastrocche e le conte cambiano di città in città, com’è giusto e ragionevole, del resto. Forse la televisione riuscirà ad imporre una certa globalizzazione anche in questo settore, ma in passato la differenza fra un bambino modenese o bolognese ed uno romano erano notevoli, anche in questo importante dominio culturale.
Quando ci trasferimmo da Bologna a Roma io avevo nove anni, frequentavo la quarta e giocavo più che potevo. Siccome la scuola statale era un po’ distante ed il percorso casa-scuola obbligava all’attraversamento di alcune grandi strade di traffico, i miei m’iscrissero ad una scuola di suore tedesche che vantava un magnifico giardino a cinquanta metri da casa.
Questo fu il solo motivo per me di quella scelta, ma, frequentandola, mi resi conto che invece i miei nuovi compagni stavano percorrendo i primi gradini preparatori ad un cursus honorum che sarebbe continuato in cattolicissime scuole superiori e, presumo, nell’Università cattolica, anticamera confortevole per una carriera politica nel partito di governo o nei meandri imperscrutabili delle capaci strutture amministrative che prosperavano all’ombra del cupolone.
 L’anno successivo, diventato più esperto del traffico, fui iscritto in quinta nella scuola pubblica: un orrendo edificio in puro stile fascista intitolato ai “Fratelli Bandiera”, sfortunati patrioti fucilati nel vallone di Rovito che, più tardi, offrirono, loro malgrado, lo spunto alle clamorose “Sorelle Bandiera” con il loro irriverente “Fatti più in là” de “L’altra domenica”: la trasmissione televisiva domenicale di Renzo Arbore negli anni ’70.
L’anno successivo, diventato più esperto del traffico, fui iscritto in quinta nella scuola pubblica: un orrendo edificio in puro stile fascista intitolato ai “Fratelli Bandiera”, sfortunati patrioti fucilati nel vallone di Rovito che, più tardi, offrirono, loro malgrado, lo spunto alle clamorose “Sorelle Bandiera” con il loro irriverente “Fatti più in là” de “L’altra domenica”: la trasmissione televisiva domenicale di Renzo Arbore negli anni ’70.
Che carriera abbiano fatto i miei compagni educati dalle suore tedesche non ho mai saputo perché rapidamente persi memoria dei loro cognomi oltre che delle loro facce; ricordo soltanto che per giocare con loro nel bel giardino romano mi toccò imparare a memoria nuove conte e aggiornare il mio dizionario dei giochi con nomi per me esotici, quali puzzico rampichino, che nel corso della vita successiva non ho poi avuto occasione di sfruttare a fondo, perfino meno del greco antico, oggetto di studio spassoso per ben cinque anni.
All’urdu non mi sono ancora avvicinato con adeguato entusiasmo.